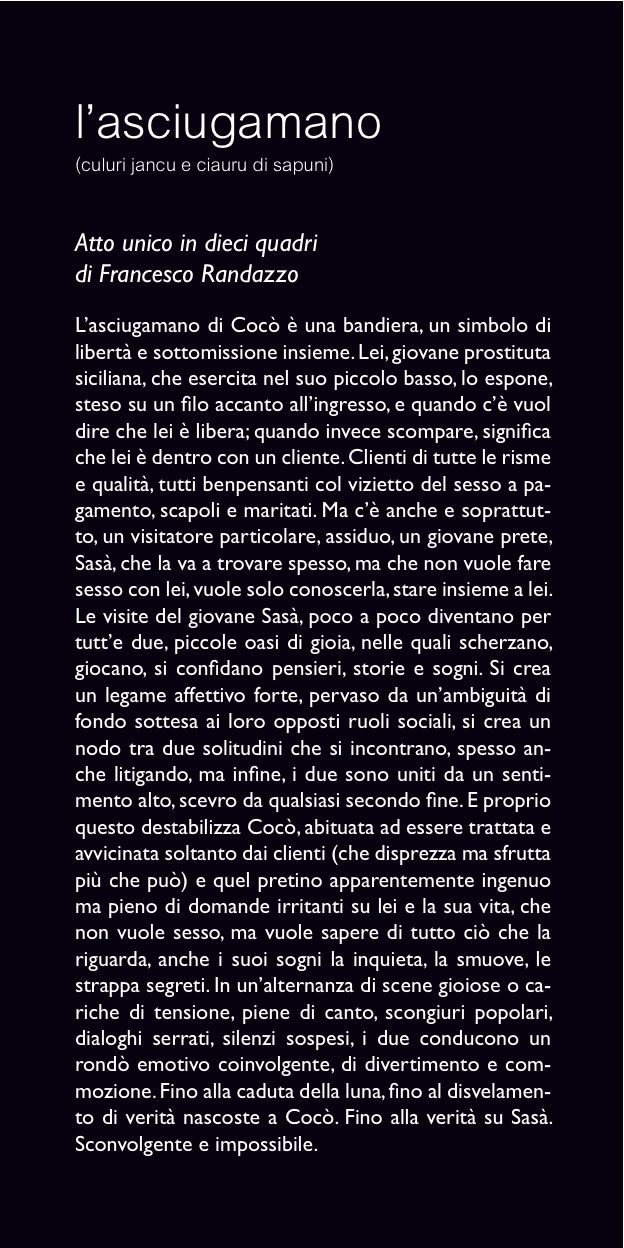5. Tommaso PincioEra la fine degli anni Ottanta, che qualcuno definisce meravigliosi, altri orribili, altri discreti, altri ancora passabili, o almeno vivibili, quando Torquatus W. Ufonson, un umano Speckerwalsh di quarta generazione che aveva già consumato tre quarti della sua vita su questo pianeta e che si affacciava proprio allora al quarto quarto trascinandosi nella più penosa tristezza, e che non aveva mai fatto del male ad anima viva, o perlomeno così aveva sempre creduto nell’ingenuità senza fondo che gli certificavano tutti, parenti compresi, ma trascorreva il suo tempo libero ― e ne aveva tanto, tantissimo, fors’anche troppo, a giudicare dalla noia che lo prendeva spesso, in certe stagioni spessissimo, e non c’era niente da fare ― trascorreva il suo tempo libero giocando con i suoi marzianini di piombo e le sue cosmonavine in miniatura di tutte le specie e dimensioni allineate sugli scaffalini di tec ben stagionato nel suo bungalow di faggio giallo sulla collina più alta della contea di Madox Springs, proprio sotto Stanford, la città più fumosa di tutto l’East Side, e questo dipendeva dalle molte fabbriche che c’erano, nessuno seppe mai di cosa, però il fumo usciva alla grande e invadeva impunemente case; polmoni. Tutto.
Quella contea godeva la fama di essere la più infame di tutti gli Stati Uniti. O almeno una delle più infami. Senz’altro. E questo non meravigliava nessuno. Non poteva meravigliare nessuno visto che la fedina penale più immacolata di Stanford registrava un elenco di crimini da far paura al più tremendo dei banditi (allora li chiamavano gangsters, cornuti, o semplicemente figli di puttana) di tutte le contee limitrofe. E non solo quelle limitrofe. Anche quelle più distanti.
Una mattina di maggio di verso la fine degli anni Ottanta, Torquatus W. Ufonson, mentre si preparava il suo green tea nella kitchen d’olivastro che aveva appena comprato a rate benché le sue magre finanze non glielo permettevano, improvvisamente e senza la benché minima possibilità di scampo, fu attanagliato da un dubbio. Un dubbio atroce, una morsa sgradita, corrosiva, che non lo mollava un solo momento, specie quando era d’umore non particolarmente fantastico, il che avveniva quasi sempre, malgrado si sforzava di non farlo succedere, e che si riaffacciava quando non se l’aspettava, tra capo e collo, e avrebbe fatto l’impossibile per cancellarlo, benché non riusciva a sentirselo come suo. Eppure lo era, suo, non c’era dubbio, non c’era il benché minimo dubbio che era suo. Ormai si era incancrenito, si era incarnito, proprio come un’unghia, nelle profondità della sua anima turbata e confusa in cui lui annaspava come un naufrago che intravede, sì, la terra e le cime degli alberi coronate di nubi e il vento che le scuote e gli uccelli che volteggiano in mezzo a nuvole di insetti di ogni specie e dimensione che vorticano nella luce che si staglia contro il mare che bolle come se una fiamma lo scaldasse nei visceri che sembrano quelli di un mostro, ma siccome sta per affogare, non ce la fa più, e allora si lascia andare pensando: se deve andare così; vada.
Ma Torquatus W. Ufonson non si sarebbe lasciato andare, mai, a qualsiasi costo, nemmeno per tutto l’oro del mondo. Ci voleva coraggio, certo. Ma a lui il coraggio non gli era mai mancato, non era mai stato un problema fin da quando suo padre gli disse, «Vai pure, ma ci vuole coraggio, se non ce l’hai c’è poco da fare». Tali parole gli riecheggiavano nell’anima spessissimo, a Torquatus W. Ufonson.
Torquatus W. Ufonson non si ricordava con precisione il momento in cui quel dubbio aveva fatto il suo primo avvento, impiantandosi per la prima volta prepotentemente e ineluttabilmente nella sua mente fremente. Perché adesso? si chiedeva, perché proprio a lui, che non aveva mai dato fastidio a nessuno, che giocava innocuamente con le astronavine e i marzianini di piombo, che si limitava ad avere un sistema di vita per cui fantasticava al massimo qualche incontro ravvicinato del primo tipo, e solo qualche volta, ma raramente, molto raramente, del secondo? Al terzo poi, non ci avrebbe mai pensato. Mai. Perché era fatto così. Non faceva mai il passo più lungo della propria gamba. Che sapeva che era cortissima, e non gli avrebbe mai consentito di fare un passo che fosse particolarmente lungo, non in senso assoluto, in senso relativo, solo in rapporto alla proprio gamba, cioè, non in relazione a tutto. Sperava solo di sfangarla, ecco tutto. Sfangarla: intorno a questa parola si era svolta tutta la sua vita. O quasi.
Non che non ci avesse mai pensato, non che non sapeva cos’era, un dubbio. Ci aveva pensato a questa cosa del dubbio, sicuro. Doveva farci una qualche cosa. Lo sapeva bene che doveva farci una qualche cosa. Solo, non adesso. Un po’ più in là. Magari a settembre. A ottobre. A novembre. O a Natale, perché no? Natale, a Madox Springs, era stupendo, tutti si compravano una camicetta nuova e buttavano la vecchia, una radio nuova e buttavano la vecchia, un frigorifero nuovo e buttavano il vecchio, chissà da dove proveniva questa tradizione molto molto originale che a Torquatus W. Ufonson faceva molto piacere osservare con molta attenzione tra le stecche delle sue persiane, mentre accendeva con molta cautela le lucine di tutte le sue astronavine o scrutava i marzianini illuminati dalla luce radente del pub sotto casa sua da dove proveniva ondeggiando nell’aria una puzza insopportabile di pancetta di terza scelta e di uova andate a male. Sarebbe sceso a litigarci di brutto con quelli là, però rimandava sempre. Di volta in volta. Come rimandava tutte le cose appartenenti alla propria vita, benché era uno Speckerwalsh, e gli Speckerwalsh, si sa, quando c’è da agire agiscono; alla grande.
Partiva da lontano quel dubbio, da molto lontano. Da così lontano che lui neanche si svegliava la mattina e quello già era pronto a bucargli il cervello, come uno che ha un trapano acceso in mano e non aspetta altro che il momento più giusto e migliore per poterlo usare al meglio contro chiunque gli capita casualmente sottomano benché è totalmente con le mani pulite, innocentissimo voglio dire.
Voleva, doveva fare una qualche cosa. Ma non ci riusciva a farla.
Qualche volta, ma molto di rado, andava al distributore automatico di gassose di Hobbes Street, che fu poi chiamata Bongo Road in onore al tamburo del primo giudice di Stanford che lo percuoteva dopo aver emanato ogni sentenza quasi per suggellarla con un ritmo che salava il sangue di tutti quelli che c’erano. Ognuno che aveva voglia di gassosa bastava dicesse: «Bongo», bastava questa parola: ciò per far capire quanto Bongo era diventato il simbolo in assoluto della gassosa; in altri termini, non dicevano più, «Voglio una gassosa», ma solo, «Bongo», e gli altri capivano al volo, dopo qualche minuto.
Andava lì, Torquatus W. Ufonson, infilava la moneta nell’apposita fessura, poi si sedeva a terra sfoggiando il suo sorriso estatico che di estatico aveva unicamente l’apparenza, perché lui all’interno si sentiva al contrario preciso dell’estasi, diciamo pure: imbestialito come un negro, benché di nero aveva solo i sopraccigli, il resto era più bianco del bianco lavato con tre passaggi a cento gradi in una lavatrice Turbomax Super 156 Tipo Extra. Infilava la moneta e aspettava paziente, pensando ai suoi marziani. Solo allora si sentiva meglio. Non proprio bene, solo meglio. Lo sapeva bene che quel dubbio lo avrebbe mollato solo qualora avesse dato una risposta ad esso. Bene. Ma come fare? Pure se avesse voluto, Torquatus W. Ufonson non ci sarebbe riuscito molto bene. Del resto, certe cose, o riescono bene, o no. E questo lo sapeva. Lo sapeva benissimo, fin nel profondo dell’essere.
Torquatus W. Ufonson si era perso. Si era perso in tanti sensi. Si era perso nel senso più generale di ostinarsi a non voler considerare l’eventualità che il mondo intorno a lui fosse reale e in quello più particolare e immediato di non sapere dove diavolo era potuta finire la Stanford di un tempo, quella della sua infanzia che correva come il fiume Zxhythwskj (qualcuno lo scriveva Yzxtvwjw, altri Xzitvs e altri ancora Ptpofak, non si capì mai la grafia esatta, finché un vecchio capo apache disse, «Si scrive Mkzxxyqiq, ecco come si scrive!»), solo che il fiume prima o poi arrivava al mare, mentre lui non arrivava da nessuna parte. Mai!
Nella contea di Madox Springs nevicava che Dio la mandava. Nevicava sempre, in ogni stagione. Nevicava come scorrevano fiumi di birra. Che a parte la neve era l’unica cosa che ti poteva venire in mente di dire su quello schifo di contea che tutti odiavano a morte e che ci avrebbero messo la dinamite e che non si decidevano invece mai a lasciare, come se ci fossero appiccicati con la colla Samson, quella che Torquatus W. Ufonson adoperava per riparare i suoi marzianini, pur se piombo e colla non è che vanno molto d’accordo, anzi; puoi provare cento, mille volte, ma due pezzi di piombo con la colla, Samson o non Samson, mica li attacchi, il piombo si fonde, altro che colla! Ci vuole un forno a più di 10.000 gradi, la colla serve per la carta, la stoffa, il legno morbido, certe volte la ceramica, eccetera eccetera eccetera. Ma il piombo…
La vita di Torquatus W. Ufonson si lasciava trasportare da una corrente di placida e morbosa malinconia che correva verso il niente, tra un marzianino da riparare e una cosmonavina da lucidare, e magari da farci un sogno, di quelli che ti lasciano un segno la mattina, quando ti svegli con il palato impastato e una voglia di caffè che si impossessa senza tregua della tua gola secca come se fosse stata bruciata da un lanciafiamme o cosparsa d’acido, ovvero cose molto simili.
E infatti. Una notte verso le tre, tre e mezza, Torquatus W. Ufonson sognò che si costruiva un’astronave vera, e che un esercito di marziani in carne e ossa lo circondava pian piano scrutandolo alla stessa maniera con cui lui scrutava i marzianini di piombo sullo scaffalino di tec.
Vale a dire: sinistramente.
Torquatus W. Ufonson se l’aspettava, in effetti. Da tanto tempo. Da una quantità di tempo che non riusciva nemmeno più a quantificarla. E finalmente era venuto il momento.
E da quel momento, del dubbio più neanche l’ombra.