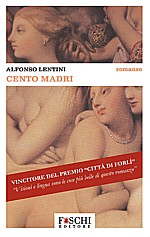Nel dicembre del 2003, una disposizione della Regione Siciliana obbligava i comuni a costituirsi in società per azioni che avrebbero dovuto gestire il ciclo dei rifiuti di ogni ATO (Ambito Territoriale Ottimale). Nell’isola ne vennero individuati un po’ meno di trenta. La norma prevedeva che se i comuni non avessero agito nel senso indicato, le procedure sarebbero state comunque condotte da un commissario ad acta, a spese degli enti inadempienti. Alla mezzanotte del 31 dicembre 2003, gli ATO erano una realtà, almeno sulla carta. A metà del 2004, quasi nessuna – e forse proprio nessuna - delle società aveva ancora raccolto un solo sacchetto della spazzatura. I comuni continuavano gestire e a pagare i servizi, anche se, formalmente, non avevano più il potere né il dovere di farlo.
Ma gli ATO non erano ancora in grado di farlo.
La situazione era discretamente ingarbugliata.
Partirono dei fax da Palermo. Erano le convocazioni di molti tavoli tecnici, uno per ogni ATO.
* * *

Mi telefona il capo.
— C’è un tavolo tecnico a Palermo.
— Devo venire anch’io?
— Vuoi venirci?
Nicchio un poco, perché col mio capo, di questi tempi, non corre sangue dolce, ma poi penso che è un buon Cristo, in fin dei conti, e forse ha bisogno di un po’ di conforto.
— C’è anche il vicesindaco.
Il vicesindaco è il prototipo di quello capitato lì per caso. Un esemplare politico tipo, che non sa nulla e ne parla come se avesse capito tutto. Soprattutto non ha mai idea di ciò che fa, ma riesce sempre a dare l’impressione di saperlo fare benissimo.
Ha vissuto per anni a carico del padre, s’è sposato a carico del padre, fino ai trent’anni ha venduto lavabi e gabinetti nel negozio del padre. A trent’anni e qualche giorno ha scoperto di avere un talento particolare nel raccontare storie alla gente. Uno con più grilli per la testa si sarebbe convinto di diventare uno scrittore. Lui no. S’è messo in politica. Ha arringato la folla dal palco dei comizi, senza tralasciare il dialogo a quattr’occhi con ogni potenziale elettore. Grazie a questo suo talento ha smesso di farsi mantenere dal padre per mettersi a carico dalla collettività. Risulta disoccupato all’ufficio di collocamento, di fatto viaggia in BMW e la moglie sfoggia pellicce e borse di Louis Vuitton. E pare che non siano imitazioni.
Mi viene in mente qualcun altro che, fino ai trent’anni ha lavorato nella bottega del padre e poi ha iniziato ad arringare folle. Ma la carriera è durata solo fino ai trentatrè. Il mio vicesindaco di anni ne ha già trentotto e tutti i tentativi di crocifiggerlo in consiglio comunale sono stati inutili. Credo sia solo una questione di aspirazioni. Si rischia parecchio a cercare di rendere migliore la gente, pochissimo a irretirla. Il mio vicesindaco ha molto senso pratico. Si accontenta del potere che gli viene dall’occupare una poltrona e di indossare abiti consoni al ruolo istituzionale. Possiede decine di cravatte deliziose. Ha un debole per le cravatte e non mette mai la stessa per due giorni consecutivi. Una volta ne ha regalata una anche a me. Il consiglio voleva una relazione sui costi annuali della raccolta rifiuti e io gliel’ho preparata a tempo di record dimenticando di dire un po’ di cosette che gli sarebbero dispiaciute. Quasi nessuno dei consiglieri s’è accorto di nulla, e chi se n’è accorto s’è ben guardato dal farlo notare. La cravatta è stato un riconoscimento alla mia perizia e un modo per dirmi che mi vedeva simile a lui: uno che spiega le cose già capite e chiarisce quelle ben chiare. In fin dei conti va bene così. Troppi dubbi non vanno d’accordo col quieto vivere e un politico che mira a numerose rielezioni non deve mai turbare il quieto vivere.
A pensarci bene, credo potrebbe fare bene anche senza di me. Anzi, no: ne sono sicuro. Ma si tratta pur sempre di un tavolo tecnico. E oggi non mi va di stare dietro alla scrivania.
— Vabbé, vengo anch’io — dico al mio capo. — Sei sicuro che si parlerà solo di rifiuti?
— Sicuro — risponde lui. — Perché, c’è il caso che si parli d’altro? — Sembra allarmato.
Il mio capo è fatto così. Sembra sicuro del fatto suo, ma ogni mia domanda rischia di gettarlo nel panico. E’ anche lui un bravo ragazzo capitato qui per caso e io sono colui che coi miei dubbi turba ogni giorno il suo quieto vivere. Prima faceva l’insegnante di liceo e spiegava ai suoi alunni le verità della matematica e della fisica. Da quando è stato assunto in comune ha scoperto che la verità si può montare e smontare alla bisogna. Mi piace immaginarlo, la mattina presto, davanti allo specchio, a interrogarsi sulla verità necessaria per il giorno che seguirà; a scegliere l’atteggiamento adeguato a spacciare per autentiche elucubrazioni di comodo e interpretazioni pretestuose di codici e codicilli. Questo è quello che immagino. Quello che so è che deve essergli costato parecchio cancellare dalla sua mente anni di formazione positivista per far tabula rasa di ogni resistenza al volere politico. Ha una grande casa con giardino, un mutuo da pagare, una moglie a carico, tre figli, i desideri propri del borghese medio-alto (l’estate in camper o in residence, visibilità sociale, un futuro senza preoccupazioni, una buona università per i figli, una pensione dignitosa) e non può permettersi troppi dubbi sui desideri del sindaco che lo paga. In fin dei conti ha ragione. Solo chi è come me può permettersi dubbi: sono scapolo, vivo con mia madre. Non mi costa molto allevare dubbi.
— Ci vediamo alle nove in piazza — gli dico.
Alle nove, puntale, sono nella piazzetta davanti all’ingresso del municipio. Nella ventiquattr’ore ho stipato una quantità di documenti e circolari che parlano di rifiuti solidi urbani. Più puntuale di me è giunto l’autista con la Thema blu con le insegne del comune. Meno puntuali giungono il mio capo e il vicesindaco, gli aliti ancora odorosi di caffè e un’ombra di zucchero a velo sul bavero delle giacche. Brevi cenni di saluto.
— Avete già fatto colazione? — chiede cordiale il vicesindaco a me e all’autista, ma è tardi e non attende risposta. Prende posto sul sedile davanti e ci fa segno di salire.
— Prendiamo qualcosa all’autogrill. — Controlla l’orologio. — Oppure a Palermo.
Montiamo tutti in macchina.
— Il presidente non ci sarà — dice seccato il vicesindaco.
— No? — fa il mio capo.
— Solo il vicecommissario.
Dalla tasca interna della giacca il vicesindaco cava un sigaro gigantesco, inizia a giocherellarci, ne taglia via un’estremità. Infine se lo caccia in bocca e l’accende.
— Non vi dà fastidio, vero? Tu fumi, no?
Mi accorgo che dice a me.
— Sì, fumo.
— Bene.
L’abitacolo di riempie di fumo ancora prima che l’autista abbia girato la chiave. Ma né lui, né il mio capo, fanno presente che loro no, non fumano.
Partiamo. Il conducente tiene a bada con perizia tutti i cavalli motore che, per adesso, si accontentano di andare al passo sotto il cofano. C’è traffico. Un colpetto di acceleratore, il sibilo del turbo che s’eccita per un paio di secondi.
— Metto il lampeggiante? — dice l’autista. Al vicesindaco brillano gli occhi, ma c’è stata maretta in consiglio, tempo fa: qualcuno ha criticato certe manie di protagonismo.
— No, vai piano, tanto è cosa di minuti.
Il paese è piccolo, i cavallini turbo possono riposare ancora un po’.
Siamo fuori dal traffico. L’ultimo semaforo e poi liberi, prima la statale, poi lo scorrimento veloce e quindi l’autostrada. Tra lo scorrimento veloce e l’autostrada una teoria di curve a gomito, inevitabile corollario delle strade di montagna. L’autista strombazza, non si sa mai, qualche camion o un autobus pieno di turisti francesi. Sarebbe ineducato dar loro il benvenuto sfasciandoci contro la fiancata, deturpare il bel logo della società di trasporti e lo sportellone del bagagliaio. Ma la strada è sgombra, sui rari rettilinei il motore riprende fiato e anche l’autista sembra distendersi e regge il volante quasi con delicatezza.
L’autostrada. A19, Catania - Palermo. Non c’è casello. Ci infiliamo dentro con due colpi di sterzo leggerissimi, quasi impercettibili, buoni giusto per assecondare il raggio di curvatura della rampa d’accesso e uscire dalla corsia di accelerazione. Il conducente (che si chiama Vito) pigia sull’acceleratore, il turbo reagisce con orgoglio. Decine e decine di cavalli vapore frustati a sangue scaricano sull’asfalto tutta l’energia dei loro garretti sotto forma di attrito tra i copertoni larghi e il fondo stradale. Quello che non va via in calore e attriti interni si trasmuta in pura velocità. Alberi e guard rail che schizzano all’indietro appena l’occhio li ha intuiti. Il vicesindaco sorride compiaciuto. Dice qualcosa su un corso di guida veloce.
— Eh, Vito? Come gli autisti seri.
Vito grugnisce qualcosa, ma non sembra troppo lusingato dalle parole del vicesindaco. Si vede che pensava di essere un autista serio anche prima che il comune gli pagasse il corso di guida veloce.
Durante il viaggio si discute. Il vicesindaco fa sfoggio di efficientismo, pragmatismo e buonismo. Con abilità acrobatica riesce a intavolare discorsi che partono dal vuoto e al vuoto pervengono, ma con il tono di chi sta enunciando profondissime massime o indiscutibili verità. Il conducente fissa la carreggiata con sguardo professionale. Gli invidio l’imperturbabilità e la guida fluida; al contempo ammiro il mio capo che riesce a dialogare col vicesindaco come se questi davvero dicesse cose sensate.
 Finalmente giungiamo nella capitale del Regno. Si stende lasciva nella grande piana retrostante il golfo, come una prostituta d’alto bordo. La Conca d’oro risplende di luce. Di limoni rimane il minimo sindacale. In compenso abbondano seconde case abusive, lottizzazioni discutibili, villaggi vacanze sorti dalla sera alla mattina, sfasciacarrozze e orribili capannoni industriali. Il vicesindaco osserva incantato lo sfacelo. Mi sembra di intuire i suoi pensieri: sta elaborando gli imput visivi e tirando un conto alla buona di quanti voti può portare la sanatoria di un capannone o la variante urbanistica per uno sfascio. Sono convinto che sia proprio questa la sua personale idea di sviluppo industriale e urbanistico. Poi mi sembra cambi espressione. Probabilmente pensa che non ha ancora abbastanza entrature e consensi in consiglio per organizzare un massacro così in grande scala del nostro territorio comunale. E il sindaco, si dice, ha convinzioni abbastanza di sinistra, addirittura ambientaliste. Gli ha riconosciuto la carica di vice solo per accordi preelettorali, ma sulle politiche del territorio la pensano in maniera diversa. Forse il vicesindaco pensa: “Pazienza, magari alle prossime elezioni.”
Finalmente giungiamo nella capitale del Regno. Si stende lasciva nella grande piana retrostante il golfo, come una prostituta d’alto bordo. La Conca d’oro risplende di luce. Di limoni rimane il minimo sindacale. In compenso abbondano seconde case abusive, lottizzazioni discutibili, villaggi vacanze sorti dalla sera alla mattina, sfasciacarrozze e orribili capannoni industriali. Il vicesindaco osserva incantato lo sfacelo. Mi sembra di intuire i suoi pensieri: sta elaborando gli imput visivi e tirando un conto alla buona di quanti voti può portare la sanatoria di un capannone o la variante urbanistica per uno sfascio. Sono convinto che sia proprio questa la sua personale idea di sviluppo industriale e urbanistico. Poi mi sembra cambi espressione. Probabilmente pensa che non ha ancora abbastanza entrature e consensi in consiglio per organizzare un massacro così in grande scala del nostro territorio comunale. E il sindaco, si dice, ha convinzioni abbastanza di sinistra, addirittura ambientaliste. Gli ha riconosciuto la carica di vice solo per accordi preelettorali, ma sulle politiche del territorio la pensano in maniera diversa. Forse il vicesindaco pensa: “Pazienza, magari alle prossime elezioni.”
Ma forse ho sbagliato tutto. Magari pensava alla corruzione nei palazzi del potere, ai bizantinismi delle leggi regionali che consentono di sanare l’insanabile (un po’ come il potere di resuscitare i morti… be’, non proprio i morti, diciamo i malati gravi), alla potenza delle lobby, ai giri di favori, alla perfetta sudditanza dei dirigenti degli assessorati.
Insomma, non so proprio cosa pensi, ma dice la prima cosa intelligente della giornata (certo, ammesso e non concesso che il soggetto dei suoi pensieri sia la città nella quale siamo diretti).
— Bottana tra le bottane. —
E tace.
La sala che ospiterà il tavolo tecnico è un cupo stanzone mal arredato. Per un po’ attendiamo in anticamera, assieme a politici e burocrati degli altri paesi e paesoni della nostra provincia. Saremo una trentina di persone.
Ci accoglie il vicecommissario delegato all’emergenza rifiuti. La carica di commissario è toccata al presidente della regione, cioè a colui che non è riuscito a evitare l’emergenza. Dal punto di vista operativo fa tutto il vicecommissario. Pensa, organizza e agisce, ligio alle direttive del commissario.
Il vicecommissario è un burocrate d’altissimo rango. Il suo curriculum è nutrito: laurea in giurisprudenza, capo del gabinetto del presidente, tante conoscenze e grande esperienza nelle arti di obbedire e comandare. Non passerà alla storia per aver risolto l’annoso problema, bensì per l’ammontare del suo stipendio.
Si accinge a presiedere il tavolo tecnico, elegantissimo nel suo completo grigio-burocratico. Ignora chi siano molte delle persone che si trova davanti ma, grazie all’esperienza che gli ha conferito il lungo esercizio del potere, riesce di primo acchito a distinguere i notabili dai burocrati, riservando ai primi saluti affettuosi e ai secondi saluti distinti.
Entriamo. Ci accomodiamo attorno a una grande tavola rotonda, come i cavalieri della tavola omonima. Al posto di Re Artù sta il vicecommissario, e di fronte a lui, come fosse un Lancillotto bicefalo, una coppia di alti burocrati regionali. Confabulano con fare confidenziale, ogni tanto ridacchiano. Colgo qualche frase in cui si parla di barche da dodici metri, di mogli che rompono i coglioni, di collaboratrici con poppe rimarchevoli. Mi chiedo che supplemento di salario percepiranno per il solo fatto di essere qui, a quest’ora, seduti a discutere degli affari propri in presenza di estranei.
 Faccio un’ultima considerazione: che i cavalieri della tavola rotonda erano meno numerosi di noi, e probabilmente per questo stavano più comodi. Ci sediamo tutti, gomito contro gomito, le valigette portadocumenti sotto il tavolo. Qualche volenteroso tira fuori degli appunti. Io sono tentato, ma decido di no. Estraggo dalla valigetta solo un bloc notes a quadretti con le prime pagine occupate da annotazioni buttate giù durante una giornata di studi sul recupero dei rifiuti da demolizione. Trecentocinquanta euro per ascoltare una mezza dozzina tra funzionari degli assessorati (gli stessi che redigono le disposizioni regionali) e docenti universitari. Le leggo velocemente. E’ già preistoria. Nuove circolari (scritte dagli stessi che avevano spiegato le vecchie), nuove interpretazioni autentiche. “Soldi buttati”. Non penso altro. Si comincia.
Faccio un’ultima considerazione: che i cavalieri della tavola rotonda erano meno numerosi di noi, e probabilmente per questo stavano più comodi. Ci sediamo tutti, gomito contro gomito, le valigette portadocumenti sotto il tavolo. Qualche volenteroso tira fuori degli appunti. Io sono tentato, ma decido di no. Estraggo dalla valigetta solo un bloc notes a quadretti con le prime pagine occupate da annotazioni buttate giù durante una giornata di studi sul recupero dei rifiuti da demolizione. Trecentocinquanta euro per ascoltare una mezza dozzina tra funzionari degli assessorati (gli stessi che redigono le disposizioni regionali) e docenti universitari. Le leggo velocemente. E’ già preistoria. Nuove circolari (scritte dagli stessi che avevano spiegato le vecchie), nuove interpretazioni autentiche. “Soldi buttati”. Non penso altro. Si comincia.
* * *
Il vicecommissario illustra a tutti il motivo della nostra presenza lì. C’è da gestire e smaltire un bel po’ di monnezza, cosa a tutti nota, ma pare che non esista un indirizzo da tutti condiviso in merito. Qualcuno obbietta che l’indirizzo, oltre a non essere condiviso, pare latiti del tutto. Che fine hanno fatto gli inceneritori ( — i termovalorizzatori, — precisa una voce), le aree per la preparazione del combustibile da rifiuti (il CDR famigerato, altrimenti noto come Combustibile Di  Ronchi, che l’esperienza campana ha consentito di conoscere bene, sotto forma di grossi cubi maleodoranti di rifiuto fasciato nella plastica così com’era, giusto la pressatura per dargli forma adeguata, e disposti in grosse piramidi di ispirazione precolombiana a macerarsi e colare liquami scuri). E gli Ambiti Territoriali Ottimali?, gli ATO, com’è ormai comune dire, o ATI, secondo la dizione di qualche addetto ai lavori rispettoso del plurale anche negli acronimi? Gli ATO, che hanno in mente di fare? Cioè, a parte insediare sceltissimi consigli di amministrazione e deliberare i compensi dei componenti?
Ronchi, che l’esperienza campana ha consentito di conoscere bene, sotto forma di grossi cubi maleodoranti di rifiuto fasciato nella plastica così com’era, giusto la pressatura per dargli forma adeguata, e disposti in grosse piramidi di ispirazione precolombiana a macerarsi e colare liquami scuri). E gli Ambiti Territoriali Ottimali?, gli ATO, com’è ormai comune dire, o ATI, secondo la dizione di qualche addetto ai lavori rispettoso del plurale anche negli acronimi? Gli ATO, che hanno in mente di fare? Cioè, a parte insediare sceltissimi consigli di amministrazione e deliberare i compensi dei componenti?
Si genera un chiacchiericcio fatto di consensi mormorati e suggerimenti a chi si è fatto portavoce del malcontento. Il commissario delegato all’emergenza non gode del consenso di tutti i soggetti interessati, soprattutto se i soggetti in questione sono rimasti fuori dalla spartizione delle poltrone in consiglio di amministrazione. Non che, strettamente, il commissario c’entri con la formazione dei CDA, ma si tratta, nella maggior parte dei casi, di politici di piccolo calibro. Hanno l’opportunità di manifestare le proprie rimostranze a qualcuno che conta e lo fanno, ancorché per interposta persona. Questo li fa sentire partecipi di un processo decisionale che, alla fin dei conti, passa sopra le loro teste, tutt’al più riconosce loro il ruolo – importante ma non essenziale – di soggetti deputati a facilitare i compiti altrui, e per questo da blandire saziando qualche appetito con le molliche che cadranno dalla tovaglia da pranzo.
Le terminologia legata ai finanziamenti europei usa due parole (sostantivo e aggettivo) che rendono perfettamente l’idea: enti facilitatori. Due parole che definiscono bene il limite delle competenze e dei poteri. Tutto è già deciso da regolamenti e protocolli d’intesa, ma la burocrazia esige il suo. L’ente facilitatore dovrà garantire che tutto scorra secondo canali preferenziali e si concluda in tempi rapidi. Intercettare il finanziamento diventa l’obiettivo primario.
Non è questo, in effetti, il ruolo di un ente facilitatore. Ben altre sono le performances (sì, proprio performances, come fosse un ballerino o un saltatore in alto) richieste all’ente: carte dei servizi, istruttorie veloci e ben delineate, uniformità di giudizio, percorsi di verifica interna, funzionari aggiornati che sappiano dove mettere le mani, programmazioni razionali e obiettivi chiari. Ma ovunque (o quasi ovunque: non poniamo limiti alla Provvidenza) nell’isola triangolare (di questa terra so, del resto dello stivale lascio dire a chi conosce) le carte dei servizi sono pii desideri o graziosi librettini colorati farciti di begli intenti, le istruttorie lunghi e tormentati percorsi a ostacoli, l’uniformità di giudizio una zavorra pesante che non consente favori agli amici, le verifiche interne formalità prive di significato. In più l’aggiornamento professionale è spesso alibi di grandi mangiate di pesce tutte spesate, e le mani è meglio che siano pochi e scelti a sapere dove metterle, ché se tutti ‘sti funzionari cominciassero a capire davvero come funziona la macchina sai che fatica tenere a bada la quantità di teste pensanti. E poi programmazioni messe insieme col bilancino del do ut des. E obiettivi fumosi, in linea con la vacuità della programmazione.
Un quadro generale che farebbe tremare le vene dei polsi. Non fosse che non ce ne frega niente. Tutti attorno a questo tavolo tondo hanno superato la fase in cui inorridivano per il marasma sudamericano in cui si cerca ogni giorno di barcamenarsi. Anzi, i migliori vengono fuori comunque. Come la necessità aguzza l’ingegno, così il caos seleziona i migliori talenti dell’improvvisazione e delle soluzioni creative. L’isola triangolare produce così, in quantità, virtuosi del cavillo, maestri delle nozze coi fichi secchi, esperti di falsi in bilancio, abilissimi redattori di documenti che discettano del nulla, valenti imbiancatori di sepolcri, farisei devoti al quattrino e nobili venditori di aria fritta. E cassandre, urlatori nel vento e donchisciotti, anche: ma ogni sistema, per quanto perfetto (e questo non lo è, anzi, funziona meglio proprio perché assai imperfetto), produce detriti.
Anche io ci ho fatto il callo. Quasi non vedo più. Accetto il disastro futuro come un destino ineluttabile, un traguardo che verrà raggiunto, prima o poi, lottando perchè il poi sia più lontano possibile, e nel mentre tirar su quanto serve per pagare il mutuo, le ferie, il cellulare nuovo, il canone della pay tv.
Il vicecommissario apre le mani con gesto da pranoterapeuta, come a imporle sull’intero uditorio (e in particolare su chi ha manifestato la vena più polemica) e forse un che di pranoterapeuta lo possiede davvero, perché cala subito il silenzio. E dice che tutti gli assessori all’ambiente dei comuni della regione… i sindaci presenti sollevano l’indice facendo presente che sono presenti di persona e non hanno incaricato né vicesindaci, né assessori per presenziare a quel tavolo tecnico… bene, che tutti i sindaci e vicesindaci e assessori dei comuni della regione, nonché tutti coloro all’uopo delegati, hanno il dovere – il dovere! - di agevolare l’azione di queste nuove società che si occuperanno della gestione e dello smaltimento della monnezza. Chiameremo queste società, per brevità, ATO, anche se, è chiaro, ogni ATO ha formalizzato concessione a una società di gestione che s’incaricherà di sovrintendere agli atti della gestione, agirà da stazione appaltante e verificherà la regolarità ed esattezza dell’esecuzione dei servizi affidati alle società appaltatrici.
— Chiaro? — chiede il vicesindaco.
— Chiaro — risponde in coro l’uditorio.
— Quindi, per darci un fil rouge da seguire nella discussione di oggi, il tema sarà la gestione dei rifiuti a livello di ambito territoriale ottimale. Problemi operativi e tecnici, chiarimenti sul disposto normativo. Siamo disponibili a fornirvi tutti i chiarimenti necessari per affrontare nel migliore dei modi il transito di competenze alla società di servizio, tenendo conto della necessità di evitare qualsiasi soluzione di continuità nell’esecuzione dei servizi di igiene ambientale, perché la transizione avvenga nella maniera più veloce ed efficiente. Vi invito a non sconfinare in polemiche e discussioni sulla programmazione già approvata e sulle direttive adottate sino a oggi. In questa sede preferiremmo limitarci a problemi di ordine tecnico, lasciando ad altre sedi più appropriate la discussione e risoluzione di problematiche di ordine eminentemente programmatico e politico. Va bene?
Annuiamo tutti come un sol uomo.
— Bene. Cedo quindi la parola ai sindaci e assessori presenti, affinché possano esprimere il loro pensiero in merito, e le loro proposte costruttive.
— Mhm, mhm! — rispondiamo tutti a bocca chiusa, facendo sì col capo.
— Cominciamo — dice il vicecommissario. — Chi inizia?
Si alzano molte mani. Il vicecommissario ne sceglie a caso una e dice: — Prego. Gli altri dopo, in senso antiorario. — E sorride soddisfatto per aver trovato immediatamente una soluzione al problema delle precedenze.
Inizia, quindi, un vicesindaco: attacca a discutere delle perplessità che nutre per questa nuova società che dovrà occuparsi della distribuzione dell’acqua. Tutti ci guardiamo reciprocamente negli occhi chiedendoci se ci stia per caso pigliando per il culo.
Il vicecommissario, a questo punto, ha capito di che pasta siamo fatti. Già lo sospettava, ma il vicesindaco che ha appena aperto bocca glielo ha confermato. Manifesta la necessità di allontanarsi per attendere a un importantissimo e improcrastinabile impegno. Annuncia che ci lascerà alle cure del Lancillotto bicefalo. Io sospetto che, semplicemente, gli scocci terribilmente stare a sentire i discorsi inconcludenti (e, visto il potere quasi assoluto attribuito al commissario delegato, pressoché inutili) dei politichetti della provincia più povera dell’isola, l’unica senza sbocco sul mare, duecentomila anime, o poco più, in tutto, provincia babba per vocazione e in tutti i sensi, pronta a vendersi per un piatto di lenticchie a chiunque abbia abbastanza potere, o prosopopea, o entrambi. Che gli scoccia però non può dirlo, perché non è elegante – siamo in democrazia, liberté, fraternité, egalité, in fin dei conti -, l’apparenza va salvata e qualcuno potrebbe avere amici che poi si lagneranno del trattamento subito dal loro protetto. Non si deve sapere in giro che i vicecommissari – persone così importanti e tanto pagate – si scocciano pure loro di fare e sentire sempre le stesse frasi inutili.
Ma prima di uscire fa notare al vicesindaco che si scusa tanto per essere stato poco felice nella sua premessa, ma gli sembrava palese – c’era pure scritto nel fax che convocava il tavolo tecnico - che qui e oggi si sarebbe parlato proprio di monnezza. Gli dispiace proprio, ripete, ma dei problemi degli ATO idrici si parlerà altrove e in un momento diverso.
Poi esce.
Il vicesindaco gaffeur, ferito nell’amor proprio e incespicando nelle parole, ci tiene comunque a dichiarare che, comunque, è d’accordo con tutto quello che è stato detto finora. Si siede con le orecchie in fiamme, consapevole dei sorrisetti ironici che lo accompagnano mentre, con gli occhi bassi, infossa la testa nelle spalle e finge di consultare gli impegni sulla sua agenda.
A uno a uno si alzano e parlano gli altri rappresentanti dei comuni.
Uno dichiara che, nella sua città, gestirà lui i rifiuti con impresa di propria fiducia per almeno altri sei mesi, attendendo che, nel frattempo, l’ATO divenga pienamente operativo (vorrebbe dire: — che decida di muovere il culo — lo so, glielo si legge negli occhi, ma non osa). Sa già che il consiglio comunale, proprio per questo, gliela farà pagare. D’altro canto, anche se decidesse di riconoscere la piena responsabilità – tecnica ed economica - dell’ATO, che per ora non è nemmeno in grado di smaltire la carta straccia dei cestini dei suoi uffici, si ritroverebbe i cassonetti traboccanti e le strade piene di sacchetti sbranati dai cani randagi, e il consiglio troverebbe da ridire lo stesso. Per questo ha deciso di immolarsi sull’altare dell’interesse pubblico e fanculo al consiglio comunale (be’, non dice esattamente “fanculo”; è un principe del foro e “fanculo”, almeno in pubblico, non lo dice, non è chic). Nessuno gli crede. Qualche malalingua avanza l’ipotesi che attenda un posto nel consiglio di amministrazione dell’ATO.
Un altro si alza e dice tante cose, e da quello che dice si capisce che di monnezza ha fatto esperienza, anche perché è proprio nel territorio del suo comune che si prevede di realizzare una discariche per rifiuti urbani. Vuole garanzie.
— Cosa farete dei rifiuti quando scoprirete che non sarete in grado di riciclarli e nemmeno bruciarli? Vero, la discarica, ma quanto tempo durerà questa discarica se arriveranno i rifiuti di tutta la provincia?
La domanda dà fastidio al Lancillotto bicefalo, che lo sommerge con una quantità di incomprensibili dati tecnici e statistici nascosti nel groviglio inestricabile di decine di incidentali. Quello alza le mani in segno di resa. Il Lancillotto bicefalo sogghigna.
Un altro ancora la butta sul sarcasmo.
— Abbiamo il la discarica quasi esaurita. Questo ATO, quando comincerà a lavorare? Ché noi l’immondizia non sappiamo più dove metterla. Oppure, almeno, diteci che ci tocca gestire i rifiuti per un tot di tempo e vedremo di arrangiarci in qualche maniera.
A questo punto il Lancillotto bicefalo capisce che con i giochi di parole non si può frenare il flusso di domande e chiarisce:
primo: che il decreto legge 269/2003 è in fase di conversione; se non verrà convertito dovrà farsi riferimento all’art. 35 della vecchia finanziaria;
secondo: che l’ATO sarà in grado di operare solo dopo aver completamente rilevato tutti i mezzi, il personale e le dotazioni finanziarie per la gestione dei rifiuti presenti nel nostro comprensorio, e che è ancora dubbio se la gestione dei rifiuti avverrà mediante esecuzione diretta o per il tramite di un partner privato scelto con procedure di evidenza pubblica;
terzo: che la validità dei contratti esistenti tra autorità cittadine e ditte private per la gestione è tutta da verificare, e che il compito di effettuare tale verifica sarà affidato allo stesso presidente dell’ATO.
Tutte cose abbastanza noiose, che vengono capite a mezzo, o anche meno, ma riscattate subito dal punto quarto: tutti noi abbiamo un morto davanti e ce lo dobbiamo comunque godere;
(risatina del Lancilloto bicefalo)
(rientra il vicecommissario);
quinto (e si torna a un linguaggio meno brillante): che entro il mese entrante saranno approvati i progetti relativi alla gestione dei rifiuti su base comprensoriale.
Approfittando del rientro del vicecommissario, un sindaco aggredisce il presidente dell’ATO, che era seduto assieme a noi, ma talmente silenzioso e defilato da nascondere sino a ora la sua presenza, facendogli presente che è impensabile sollevare completamente i comuni dal compito di gestire il ciclo dei rifiuti. Come dire che se pensa di gestirsi tutta la faccenda solo lui con la sua società é segno che non ha ancora capito bene da che parte sorge il sole e dove va a dormire. Poi si siede sbuffando.
Il presidente dell’ATO sorride sardonico. Non sfugge a nessuno. Il significato è chiaro: gli è ben noto il percorso degli astri, forse è l’altro che ha perduto le ultime puntate dello sceneggiato. E comunque lui, il presidente, è tanto ben protetto da quegli astri, che non ha nemmeno bisogno di ribattere a quelli che straparlano senza neppure saper bene di cosa.
Lo conferma l’atteggiamento del vicecommissario, che anziché intervenire passa la parola a un sindaco che già aveva parlato prima, quello che chiedeva garanzie sulla durata della discarica. Ma quello si alza solo per dire una cosa estremamente ingenua, rimossa dalla memoria appena sentita. Resosi conto si risiede e anche lui inizia a compulsare un’agenda.
Si alza quindi il sindaco del capoluogo di provincia.
— La nostra discarica sta per esaurirsi. — Come se mettesse una mano sul cuore. — Non parlo solo per la mia, ma per le altre città che conferiscono proprio nella nostra discarica. — Elenca le città in questione, compresa la mia. Noto che bara, perché alcune di queste città, compresa la mia, è da parecchio che trasportano la propria monnezza in discariche di altre città. Il sindaco del capoluogo, intanto, insiste che ci vogliono soldi per ampliare la discarica, e il commissario deve cacciarli fuori. Altrimenti chiuderà e che si arrangino, tutte ‘ste città che conferiscono eccetera eccetera.
Parla un sindaco che amministra il più piccolo comune della provincia. E’ il decano dei sindaci e vanta un passato da onorevole regionale. Tutti lo considerano con un misto di rispetto e di tenerezza. Mentre gli altri peroravano cause di campanile, s’è scritto un bel discorso e ora lo recita con tono accorato. Un po’ va a braccio. Dice di tutto un po’, tipo che l’ATO è necessario ma occorre stare attenti ai costi di gestione, che ci saranno ritorni indiretti, che ci vuole coraggio per il bene della comunità, che ci sarà un aumento dei costi ma che non ci sarà aumento dei costi. Dice molte cose, in effetti, parecchio più di quello che riesco a tenere a mente. Provo ad annotare le sue parole, ma trovo enormi difficoltà. E’ retorico ed ellittico in maniera stupefacente, non riesco a individuare il soggetto del discorso, non si capisce se sia pro o contro qualcosa, o anche se solo sia neutrale. Spesso afferma un cosa e la nega subito dopo.
Un altro sindaco parte piano. Dice: — Gestiremo i rifiuti noi fino a tutto il 2004. Abbiamo una discarica efficiente e vorremmo che continuasse l’attività” (ed è chiaro perché: la società che ha costruito e gestisce la discarica paga un tot di royalties al suo comune, la stessa società che, qualche tempo più avanti, si vedrà affidare l’appalto per la gestione di tutti i rifiuti dell’ATO).
Dice anche: — Condividiamo le scelte —. Ma non lo dice come dicono in tanti, perché è di moda dirlo. Sembra convinto. Ha un’oratoria fantastica e finisce l’intervento con una frase a effetto. Io quasi parto con l’applauso. Poi sento qualcuno che lo chiama avvocato e ci rimango male. Maturo la quasi certezza che non pensava nemmeno un quarto di quello che ha detto.
Un vicesindaco.
— Abbiamo provato ad aumentare i tributi locali per affrontare l’emergenza. Ci si sono rivoltati contro. Non abbiamo intenzione di continuare su questa strada. Che ci pensi l’ATO.
Si alza un altro sindaco. Ci racconta un po’ di fatti suoi che non interessano a nessuno.
L’ennesimo sindaco. Si capisce subito che per lui il problema della gestione dei rifiuti coincide con quello di scaricare la responsabilità su qualcun altro. Tenta di dimostrare che il compito di garantire il passaggio delle consegne dal comune all’ATO spetta al commissario delegato e, proprio dai dirigenti del commissariato vorrebbe istruzioni su come fare. Insomma vorrebbe sapere come scaricare la patate bollente chiedendolo ai destinatari della patata..
Ancora un altro sindaco. Anche lui ci racconta un po’ di fatti suoi.
Il sindaco del comune città più piccolo delle provincia riprende la parola e dimostra la sua abilità di giocoliere (l’esperienza di Sala d’Ercole è oro!). Entra nel discorso a occhi chiusi e gestisce tre argomenti diversi senza confondersi ma confondendo gli interlocutori. Alla fine chiede: — E’ Chiaro? — Nessuno ha il coraggio di rispondergli di no.
Un Vicesindaco ci intrattiene con alcuni minuti di bla bla bla che non cambiano la storia né la giornata e non meritano più di ventisei parole.
Ancora un sindaco.
— Se l’ATO non parte, ma i sindaci non sono più legittimati a norma di legge a gestire i rifiuti, chi raccoglie i rifiuti? E visto che abbiamo stanziato dei soldi per costruire una piccola discarica, è ancora il caso di spenderli, considerato che poi l’ATO si prenderà tutto?
A questo punto aspetto con ansia l’intervento del mio vicesindaco. Non che mi attenda granché, ma è pur sempre il vicesindaco della mia città. Un moto di orgoglio campanilistico mi sale nel cuore. Cerco di attirare la sua attenzione su alcune cosette che ho annotato, domande brevi e tecniche che potrebbe porre al vicecommissario. Con la mano fa segno che non serve. Eccolo, si erge in tutta la sua altezza, prende fiato, parla. Tiene banco per dieci minuti, bravissimo a non dire assolutamente nulla. Più che altro rimastica concetti già formulati da altri, senza prendere posizione pro o contro. La finestra è aperta, per fortuna; le banalità dette volano fuori senza provocare danni a nessuno.
Il Lancilotto bicefalo si frega le mani. Ora che ha raccolto tutte le obiezioni e appreso da chi possono giungere le obiezioni più pertinenti sa di aver poco da temere. Dopo avere scambiato uno sguardo d’intesa con il vicecommissario inizia a mitragliare risposte un po’ a casaccio, cosa non difficile, poiché gran parte dei partecipanti, per tipica abitudine politica, ha dimenticato le domande. A ognuno garantisce pronta e pertinente spiegazione, salvo poi evitare di darla. Deve vendere fumo e si vede. Ma è furbo. Ogni tanto ci mette in mezzo un poco di arrosto.
Parte una domanda. Come può l’ATO garantire, come pare stia facendo, di non mutare nulla nel modo di gestire i servizi in ogni città, e ottenere al contempo, economie di scala? Sono davvero così bravi? Erano organizzati così male i servizi? Lancillotto porta avanti un discorso di scelte e responsabilità condivise. Non capisco cosa voglia dire in termini pratici. Ma i convenuti sembrano convinti e contenti.
Ecco, la seduta è terminata. Si è fatto pomeriggio inoltrato. Ho una fame da non dire e non sono il solo. Ce ne torniamo a casa con gli stessi dubbi di inizio mattina (almeno chi dei dubbi li aveva). La fame ottunde la capacità di giudizio e non sono venute più fuori domande. Il vicecommissario ci congeda. Finalmente fuori.
Il mio capo e il vicesindaco chiedono a me e Vito se abbiamo fretta di tornare a casa o se ci va di mangiare qualcosa nella capitale del Regno. Accendo il cellulare e comunico a mia madre che, per inderogabili motivi di servizio, dovrò far tardi.
Il pranzo a base di pesce in un tipico locale palermitano è quasi una merenda. Non è un granché. Il vicesindaco promette di offrire lui, ma alla fine finge di dimenticarselo perché il mio capo gli fa notare che l’economo comunale non gli rimborserà tutta la spesa. Quindi, alla fine, si fa alla romana, tanto ci spetta il rimborso del pranzo.
Ma io perdo la fattura.
La riunione tecnica di cui si parla si svolse realmente nel 2004 e i fatti andarono, grossomodo, come descritti. Qualcosa è frutto di fantasia, ma giusto qualcosa. Mi interessava soprattutto annotare i fatti di quel giorno e le sensazioni che provai ascoltando le parole dei convenuti. La maggior parte dei quali, mi sembrò d’intuire, non aveva un’idea chiara di ciò che stava facendo (almeno secondo il mio metro di giudizio), ma sembrava infischiarsene perché erano “altre” le logiche, “altri” gli obiettivi. I rifiuti erano per alcuni solo un grosso grattacapo, per altri una gallina dalle uova d’oro. E nessuno sembrava darsi pensiero per la salute della gallina.
Il disastro era prevedibile già da queste prime premesse.
Nel 2009 gli ATO sono in crisi. Costose, elefantiache macchine mangiasoldi zavorrate di amici di e figli di buone madri e buoni papà, che non furono create per raccogliere l’immondizia e infatti non ne raccolgono quasi più.
Per approfondire
9online. Sicilia: Piano Rifiuti, un fallimento da 1,4 mld
Anonimo francese. La gallina dalle uova d’oro
Attilio Bolzoni. Regione Sicilia, il boom degli stipendi d’oro. Citato in “La regione dei nababbi”,
Commissario delegato all’Emergenza rifiuti. Selezione di alcune circolari e disposizioni.
Franco Crisafi. Selezione di articoli di stampa
Massimo Greco. Ma cos’è l’ATO rifiuti? (aggiornamento)
Gianluca Ricupati. I (dis)servizi dell’ato rifiuti
Carlo Ruta. Logiche di un potere siciliano. L’Arra di Felice Crosta
Agostino Spataro. Gestione rifiuti in Sicilia: un’idra dalle 27 teste