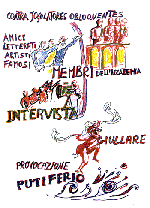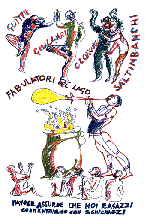Il poeta e il politico
“Lunga è la notte che non trova mai giorno”: sono parole di Shakespeare nel Macbeth e ci aiutano a determinare una condizione del poeta, al quale in un primo tempo il lettore appare da un’immagine della sua solitudine con volto e gesti del compagno d’infanzia; forse di quello più sensibile, esperto di letture segrete, ma un po’ inquieto nel giudizio su una pretesa rappresentazione o violenza del mondo tentata con parole su cui cadono accenti determinati, e con misure rigorose estranee alla scienza.
Ripetere un uomo è per il poeta la negazione della terra, l’impossibilità dell’essere, benché la sua maggiore domanda sia quella di parlare a molti uomini, di aggiungersi ad essi con alcune armonie sulla verità delle cose o della mente. L’innocenza è una qualità acuta, talvolta, e permette figurazioni estreme del sensibile; e quella del compagno che costringe, dialettico, i primi numeri poetici in forma logica, resterà un punto di riferimento esatto, un fuoco che permette la costruzione della metà di una parabola. Gli altri lettori sono i poeti antichi, che guardano da una distanza incorruttibile le nuove carte; le loro forme resistono, e altre è difficile metterne vicino.
Lo scrittore di racconti, di romanzi, si ferma sugli uomini, li imita; consuma personaggi; il poeta, nella sua oscura sfera, con infiniti oggetti, è solo, e non sase sia indifferenza, la sua, o speranza. Più tardi, quel volto unico si moltiplicherà, quei gesti costituiranno figure, consensi o contrasti. Questo avviene alla pubblicazione delle prime poesie, quando scoccano i previsti allarmi, perché, e occorre dirlo ancora, la nascita di un poeta che dalla corda del cerchio della casta letteraria tenta di raggiungere il centro, è sempre un pericolo per il costituito ordine culturale.
Strano pubblico ha ora, col quale comincia ad avere silenziosi rapporti armati: critici, professori di provincia, gente di lettere. La maggior parte di queste persone, nella giovinezza ragionevole del poeta, distruggono le metafisiche, operano sulle immagini; sono i giudici astratti: correggono, su poetiche differenziali, poesie “sbagliate”.
La poesia è anche la persona fisica del poeta; e benché una separazione privata non sia possibile, non stimolerò motivi di autobiografia parlando della mia patria, che, come ognuno sa, è fitta in ogni secolo di Giovanni Della Casa, di letterati, cioè, di pulizia metrica e di adulta genialità. Questi battezzatori della tradizione hanno chiaroveggenza e fantasia, e sono fanatici, anche, di allegorie sulla credibile rovina del mondo. Non tollerano cronache, ma figure ideali, atteggiamenti: la storia della poesia è per loro una galleria di fantasmi. Anche la polemica ha una base, se si considera che la mia ricerca poetica si svolge in periodo di dittatura e segna le origini del movimento culturale dell’ermetismo.
Dal mio primo libro, pubblicato nel 1930, al secondo, al terzo, al quarto (una traduzione dai Lirici greci uscita nel 1940) non riuscivo a vedere, attraverso lo spessore politico e l’avversione universitaria a forme di poesia crudeli e distaccate dalle composizioni classiche, che un pubblico di lettori stratificato, umili o ambiziosi. I Lirici greci, e fu il principio di una più vera lettura dei classici in tutta l’Europa, entrarono nuovi nella generazione letteraria di quel tempo. Questi giovani, sapevo, scrivevano lettere d’amore citando versi delle mie liriche, mentre altri ne apparivano sui muri delle prigioni, segnati dai condannati politici. In che tempo ho scritto poesie, abbiamo scritto versi, per scendere, senza perdono, nella più acre solitudine! Categorie dello spirito, verità? L’antica poesia europea, libera, ignorava la nostra presenza: la provincia latina asservita ai cesarismi, maturava già sangue, non lezioni di umanesimo.
I miei lettori erano ancora letterati; ma ci doveva essere altra gente che aspettava di leggere mie poesie. Studenti, impiegati, operai? Avevo cercato verosimiglianze astratte? Una delle più rudi presunzioni? Era invece un esempio di come si forza la solitudine. La solitudine, “la lunga notte” shakespeariana, mal sopportata dal politico – che voleva il Tirteo durante le stagioni africane o russe – si determinava chiara come poetica: accettata in quelle forme che sembravano continuare il decadentismo europeo, ed erano invece le prime architetture di neo-umanesimo. La guerra, ho sempre detto, costringe a nuove misure l’uomo di una patria vinta o vittoriosa. Le poetiche e le filosofie si spezzano “quando cadono gli alberi e le mura”: troppo facile sarebbe riprendere nel punto interrotto dal primo urto atomico i residui formali che legavano l’uomo a un tempo del decoro e della virtù fonetica.
Dopo il ribollire della morte anche i principi morali vengono messi in discussione e le prove della religione anche: i letterati appesi agli esiti privati delle loro minute estetiche vengono staccati dalla inquieta presenza della poesia. Il poeta, dalla notte, cioè dalla solitudine, trova il suo giorno e inaugura un diario mortale per gli inerti; il paesaggio oscuro cede al dialogo. Il politico e gli alessandrini con le corazze dei simboli e delle purezze mistiche fingono di ignorare il poeta. È una storia che si ripete come il canto del gallo, anzi come il terzo canto del gallo.
Il poeta è un irregolare e non penetra nella scorza della falsa civiltà letteraria piena di torri come al tempo dei Comuni; sembra distruggere le sue forme stesse e invece le continua; dalla lirica passa all’epica per cominciare a parlare del mondo e di ciò che nel mondo si tormenta attraverso l’uomo numero e sentimento. Il poeta comincia allora a diventare un pericolo. Il politico giudica con diffidenza la libertà della cultura e per mezzo della critica conformista tenta di rendere immobile lo stesso concetto di poesia, considerando il fatto creativo al di fuori del tempo e inoperante; come se il poeta, invece di un uomo, fosse un’astrazione.
Il poeta è la summa delle diverse “esperienze” dell’uomo del suo tempo, ha un linguaggio che non è più quello delle avanguardie, ma concreto nel senso dei classici. Eliot dice a questo proposito che quella di Dante “è la lingua comune allo stadio perfetto … tuttavia il semplice stile, del quale Dante è il più grande maestro, è un difficilissimo stile”. Occorrerà insistere su questo linguaggio, che non è quello dei parnassiani e degli inventori di crisi nel corpo della lingua di ogni paese, dove la contaminazione con i dialetti non crea che altri dubbi e geroglifici letterari; perché non saranno mai i filologi a rinnovare la lingua scritta: è un diritto che spetta ai poeti. Il linguaggio dei poeti è difficile non per ragioni di filologia o di oscurità spirituali, ma in virtù dei contenuti. I poeti possono essere tradotti: è impossibile tradurre i letterati, perché essi affidano al loro artigianato intellettuale le tecniche di altri poeti, perché difendono il simbolismo o il decadentismo per assenza di contenuti, per pensiero da aggiungere ad altro pensiero umano, per verità delle quali teoricamente si sono nutriti richiamando Goethe o i grandi poeti dell’Ottocento francese. Restare nella propria tradizione, evitare l’internazionalismo, è quello che fa il poeta. I letterati pensano all’Europa o al mondo in funzione di poetiche che si ripiegano su se stesse, come se la poesia fosse un “oggetto” identico su tutta la terra. Poi, a questa accettazione delle poetiche, il formalismo preferisce alcuni contenuti e ne allontana altri con violenza, ma il problema, da una parte e dall’altra della barricata, è sempre sui contenuti.
La parola del poeta, così, comincia a battere con forza sul cuore dell’uomo di ogni razza, mentre il letterato purissimo considera sé nel mondo e il poeta costretto nella provincia, con la bocca spezzata dai suoi trapezi sillabici. Il politico si serve del letterato che non ha una posizione spirituale contemporanea, ma superata almeno di due generazioni, e dell’unità della cultura fa un gioco di scomposizioni sagge e turbolente, dove il fattore religioso può spingere ancora a imprigionare l’intelligenza dell’uomo.
Poesia religiosa, poesia civile, poesia lirica o drammatica: categorie delle espressioni dell’uomo, valide se valida è la sollecitazione dei contenuti formali. Errore credere che una conquista dell’anima, una situazione particolare e individuale del sentimento (quella religiosa) possa diventare per estensione “società”. La disciplina ascetica, la rinuncia dell’uomo verso l’uomo non è che una formula della morte. Lo spirito “operante” cade sempre nella tagliola dei lupi: il suo discorso parlato dipende spesso da una mistica, dalla libertà dell’anima che si trova schiava sulla terra. E spaventa il suo interlocutore (la sua ombra, oggetto da disciplinare) con immagini della decomposizione fisica, con un’analisi compiaciuta dell’orrido. Il poeta non teme la morte, non perché egli entra nella fantasia degli eroi, ma perché la morte è una visitatrice continua dei suoi pensieri e quindi l’immagine di un dialogo sereno. Di fronte a questo distacco egli trova la figurazione dell’uomo, che chiude dentro di sé il sogno, la malattia, la redenzione dalla miseria della povertà, che non può essere più per lui un segno dell’accettazione della vita.
Per rendersi conto dell’influenza che esercita il politico, e in questo termine comprendiamo anche il potere religioso, basti pensare al silenzio di un millennio nel campo della poesia e delle arti dopo la fine del mondo classico, o alla grande pittura del Quattrocento, periodo in cui la Chiesa era il datore di lavoro e ordinava i suoi contenuti.
La critica formalistica cerca di colpire il concetto dell’arte sulle ragioni delle forme e avanza riserve sulla consistenza dei contenuti per incidere in senso assoluto sulla sua autonomia. Infatti, la poesia non accetta i tentativi “missionari” del politico, né l’intervento della critica che ha origine da una qualsiasi filosofia. Il poeta non subisce deviazioni morali o estetiche; di qui, in un certo tempo, una sua doppia solitudine nei confronti del mondo e delle milizie letterarie.
Esiste, intanto, un’estetica contemporanea? E da quale filosofia si possono ottenere suggerimenti attivi? Una poesia esistenziale o marxista non si è ancora puntualmente fermata sul quadrante letterario; il dialogo o il coro delle nuove generazioni presuppongono una crisi, che è anche una crisi dell’uomo, e di questa confusione il politico si serve per creare quelle zone di stabilità illusoria di una poesia frantumata.
Il dualismo tra il politico e il poeta in senso generale è risultato evidente nella cultura di ogni tempo e oggi i due blocchi che governano il mondo si formano ragioni di libertà contraddittorie, quando è chiaro che per il politico non c’è che una libertà e in una sola direzione. Difficile spezzare questa barriera che ha macchiato di sangue la storia della civiltà. Esistono sempre almeno due modi di considerare la libertà della cultura: la libertà nei paesi dove avviene un rivolgimento sociale profondo (la Rivoluzione Francese, per esempio, o la Rivoluzione d’Ottobre) e quella degli altri, che prima di subire una modifica nel modus di concepire il mondo resistono a lungo nelle loro roccaforti.
Ci può essere un coordinamento fra il politico e il poeta? Forse dove esistono delle società in formazione, ma mai sul piano della libertà assoluta. Nel mondo contemporaneo il politico assume vari aspetti, ma non sarà mai possibile un accordo col poeta, perché uno si occupa dell’ordine interno dell’uomo e l’altro dell’ordinamento dell’uomo. L’ordine interno dell’uomo può coincidere, in una data epoca, col desiderio dell’ordinamento-costruzione di una nuova società.
Il potere religioso, che molto spesso si identifica con quello politico, come ho già detto, è sempre stato protagonista di questa dura lotta anche quando sembrava laterale. Le ragioni per le quali il poeta diventa un pericolo per il politico (poeta come indicatore della morale del proprio popolo) sono sempre quelle di cui parla Giovanni Villani nella sua Cronica a proposito di Dante: che per i suoi contemporanei “bene si dilettò in quella commedia di garrire e sclamare a guisa di poeta, forse in parte più che non si convenìa: ma forse il suo esilio glielo fece fare”.
Dante non scrive cronache come il Villani e accanto alle dolcissime poesie ermetiche della scuola del dolce stil novo più tardi aggiungerà, senza tradire la sua integrità morale, la violenza delle invettive umane e politiche, non dettate dall’odio ma dalla giustizia interna e religiosa in senso universale. Dinanzi a questi numeri brucianti in eterno, gli esteti sono stati cauti mettendoli nel limbo della non-poesia. Più sensati poeticamente sono apparsi sempre versi come “Trivia ride tra le ninfe eterne” che non il vituperio dei pisani, il fuoco liquido sui fiorentini, che bruciò per secoli la città gentilissima di Beatrice. La poesia di Dante ha creato sospetti, nel nome stesso della sua grandezza, e il falso culto della sua memoria anche oggi non è che retorica, tanto pochi sono gli ascoltatori della sua umana Commedia. Ogni nazione ha dei poeti che stanno sulla stessa linea della civiltà di Dante. Ricordiamo Schiller, per i tedeschi, Shakespeare, per gli inglesi, Molière e Corneille, per la Francia, Cervantes, per la Spagna, Dostoevskij, per la Russia; e i moderni lasciamoli per il momento nella loro serenità armata nei diversi luoghi della nostra terra.
I tentativi di distinguere, avvicinare o allontanare il politico e il poeta, questi due “tipi” delle società di ogni tempo, sono comunque valsi a stabilire una condizione almeno storica. Se io volessi aggiungere ai due sostantivi l’attributo “uomo”, aumenterei l’intensità specifica del poeta e ridurrei quella dell’altro tipo a uomo politico, mentre io per politico intendo il denominatore comune di una rosa di numeri politici, cioè legati tra loro da ideologie più o meno equivalenti.
Nessuno ignora la funzione del poeta nella struttura della società esistente o in evoluzione. L’importanza di un Baudelaire, di un Mallarmé, di un Rimbaud, come costruttori di un “modo” di vita nella compagine nazionale francese, è oggi più evidente che non ai contemporanei, quando si poteva pensare che la loro poesia non fosse che una sinuosa avanguardia letteraria, rifrazione di una lingua costretta a piegarsi a sintassi liriche provvisorie. Riconosce il politico questa forza attiva del poeta nella società? Pare di si, e a dimostrarlo basterebbero le varie forme di elusione o di asservimento degli uomini di cultura, qui sono costretto a ripetermi, nelle società di ogni tempo.
L’intelligenza creativa è stata sempre ritenuta un contagio mortale. Di qui le varie ragioni del mecenatismo delle corti medioevali – i premi cavaliereschi o mansuetamente eroici, le interminabili fiorettature di madrigali – mecenatismo che si è trascinato fino alle soglie del nostro secolo, quando, in virtù di una potenza riflessa dell’intelligenza, la borghesia costruiva il suo stato di libertà. Qualcuno potrebbe osservare, risalendo nel tempo, che Piatone, quale architetto di uno Stato ideale, escludeva da questo i poeti, come elemento di disordine (o di ordine, si dovrebbe dire, considerando la loro possibilità di scardinare una società ordinata su basi antidemocratiche) ma l’ostracismo del filosofo non era che un’altra forma d’elusione.
Oggi il poeta è libero? È libero, secondo le società che lo esprimono, o il continuatore di illuminazioni pseudo-esistenziali, il decoratore dei placidi sentimenti umani, o chi non scende profondamente nella dialettica del proprio tempo per timore politico o per inerzia. Era libero, nel Quattrocento, per esempio, Angelo Poliziano, che in una delle Stanze per la Giostra di Giuliano de’ Medici con cautela fa andare alla messa domenicale una ninfa confusa in mezzo alle dame secolari, ma non Leonardo da Vinci, scrittore di altro genio. Qui libertà assume il suo vero significato: il consenso, cioè, da parte del potere politico, consenso che permette al poeta di entrare senza armi nella società. Non erano liberi neppure Ariosto o Tasso, l’abate Parini, Alfieri, Foscolo: la retorica dei sacrificati li pone poi nel tempo fra i continuatori della voce dell’uomo che sembra gridare nel deserto e invece corrode la non-verità.
Ma, a sua volta, è libero il politico? No. Infatti, sono le caste che lo assediano che decidono le sorti di una società e agiscono anche sul dittatore. Intorno a questi due protagonisti della storia non liberi e avversari (nel poeta comprendiamo tutti gli scrittori determinanti di una data epoca) circolano e si avventano le passioni e non c’è quiete che durante una rivoluzione o una guerra: la prima portatrice di ordine e l’altra di confusione.
L’ultima guerra è stata uno scontro di sistemi, di politiche, di ordinamenti civili, nazione per nazione: violenza per ritorcere anche le minime libertà. Ricompare un senso della vita proprio nella resistenza interna all’invasore nemico e familiare. Resistenza della cultura e dell’umanesimo contadino che “alzò il capo nei campi aspri”, come dice Virgilio, contro i potenti.
Da questo movimento armato si stacca, in ogni paese, una corrente culturale non provvisoria, come pensano i conservatori delle ipoteche eterne sul-l'”immobile” civiltà. Insisto nel dire non provvisoria, perché il nucleo della cultura contemporanea (compresa la filosofia dell’esistenza) è orientato non verso i disastri dell’anima e dello spirito, ma verso un tentativo di riunire le giunture spezzate dell’uomo. Non sarà né la paura, né l’assenza, né l’indifferenza, né l’impotenza a dare al poeta la parola per comunicare agli altri una sorte non metafisica.
Il poeta può dire che l’uomo comincia oggi; il politico può dire o dice che l’uomo c’era e può sempre essere preso al laccio della sua viltà morale, viltà non congenita ma insinuata da una lenta frana secolare.
È una verità che si nasconde negli atteggiamenti irraggiungibili della sapienza politica e suggerisce una prima conclusione, e cioè che il poeta può parlare soltanto negli intervalli della barbarie. La Resistenza è una sicurezza morale, non è una poetica; né il poeta, dalla sua sostanza, governa parole per punire qualcuno. Il suo giudizio è di ordine creativo, non si formula in decalogo per inventare “vaticini”.
Gli europei conoscono la misura di questa Resistenza; è davvero la sezione aurea della coscienza moderna. Anche se urla, il nemico della Resistenza è oggi un’ombra con una debole legge: la sua voce è più impersonale dei suoi propositi. La sensibilità del popolo non s’inganna sulla condizione del poeta, né su quella del suo avversario. Quando l’antitesi si accresce, è la poesia che sostituisce il pensiero subordinato del politico, che della poesia fa un’idea da spegnere o da sfruttare.
La Resistenza è l’immagine perfetta del conflitto tra l’essere e il passato. Il linguaggio del sangue non è soltanto dramma nel senso fisico, ma espressione conclusiva d’un processo continuo alla “tecnica” morale dell’uomo. L’Europa è nata dalla Resistenza e l’adulazione delle figure indeterminate di un ordine che la guerra voleva fondare sono rovesciate fin dalle radici. La morte ha un sonno autonomo, e disumana è una mediazione per sollecitarlo con la logica o con l’abilità dell’intelligenza politica. La lealtà della poesia si delinea in una presenza che è fuori dall’ingiustizia e dall’intenzione della morte. Il politico vuole che l’uomo sappia morire con coraggio, il poeta vuole che l’uomo viva con coraggio.
Mentre il poeta è cosciente del potere del politico, questi si accorge del poeta soltanto quando la sua voce raggiunge profondamente i diversi strati sociali, quando cioè dalla lirica o dall’epica si rivelano, oltre alle forme, anche i contenuti. Da questo momento comincia una lotta sotterranea tra il politico e il poeta. Nella storia i nomi dei poeti esiliati vengono fuori come dadi mortali, mentre il politico, verbalmente, sostiene la cultura, ma in realtà tenta di ridurne la potenza: il suo scopo non è altro in ogni secolo che quello di togliere tre o quattro libertà fondamentali all’uomo, affinchè esso continui, in questo suo eterno cerchio, a riprendere ciò di cui è stato saccheggiato.
Nel nostro tempo la difesa del politico nei confronti della cultura e quindi anche del poeta si esercita scopertamente o oscuramente su molteplici vie; la più facile è quella della degradazione del concetto di cultura. I mezzi meccanico-scientifici, radio e televisione, lo aiutano a rompere l’unità delle arti, a favorire le poetiche che non disturbano neanche le ombre. Di queste poetiche, le più preferite sono sempre quelle che si legano ai richiami delle Arcadie, per disprezzare creativamente il nostro tempo. In questo senso va inteso il significato del verso di Eschilo “Dico che i morti uccidono i vivi” messo come epigrafe nel mio ultimo libro La terra impareggiabile. In questo libro il paragone dell’uomo è la terra; e se parlare dell’intelligenza dell’uomo costituisce peccato, possiamo anche dire che il potere religioso – l’aggettivo laica che qualifica l’intelligenza vuole appunto non determinarne una qualità ma il valore intrinseco – va oltre i suoi confini esercitando la sua forza sugli umili e non sull’interno fuoco delle coscienze.
La degradazione del concetto di cultura operata sulle masse, che credono cosi di affacciarsi ai paradisi del sapere, non è un fattore politico moderno, ma nuova e più rapida è la tecnica usata per la dispersione multipla degli interessi meditativi dell’uomo. L’ottimismo è divenuto tangibile, non è che un gioco della memoria, i miti e le favole (l’ansia degli eventi soprannaturali, diremo) scendono nel “giallo”, assumono metamorfosi visive nel cinema o nel racconto epico dei pionieri o del delitto. L’alternativa fra il poeta e il politico è esclusa. L’ironia “dei circoli mondani”, che talvolta è una faccia dell’indifferenza costruita, riduce la cultura nell’angolo cupo della sua storia, affermando che il quadro del dissidio è drammatizzato, che l’uomo e il suo dolore sono stati e saranno nel loro recinto consueto, cosi negli evi come oggi e domani. Certamente. Ma il poeta sa che c’è un dramma, esasperazione del dramma, sa che gli adulatori della cultura sono i suoi fanatici incendiari: il collage degli scriventi composto su qualsiasi regime corrompe alla periferia e al centro i gruppi letterari, che stimolano l’eternità con smilze calligrafie dell’anima, con vernici della loro impossibile vita della mente. In particolari momenti della storia, la cultura si unisce segretamente contro il politico: è un’unità temporanea e serve da ariete per abbattere le porte della dittatura. Sotto ogni dittatura si stabilisce questa forza, quando essa coincide con la ricerca delle libertà elementari dell’uomo. Questa unità scompare allorché, sconfitto il dittatore, risorge la catena delle fazioni.
Il poeta è solo: il muro di odio si alza intorno a lui con le pietre lanciate dalle compagnie di ventura letterarie. Da questo muro il poeta considera il mondo, e senza andare per le piazze come gli aedi o nel mondo “mondano” come i letterati, proprio da quella torre d’avorio, cosi cara ai seviziatori dell’anima romantica, arriva in mezzo al popolo, non solo nei desideri del suo sentimento, ma anche nei suoi gelosi pensieri politici.
Non è retorica, questa: in ogni nazione l’assedio silenzioso al poeta è coerente nella cronaca umana. Ma i letterati appartenenti al politico non rappresentano tutta la nazione, servono soltanto, dico “servono”, a ritardare di qualche minuto la voce del poeta dentro il mondo. Col tempo, secondo Leonardo, “ogni torto si dirizza”.
Salvatore Quasimodo
Discorso per il Premio Nobel, 1959.